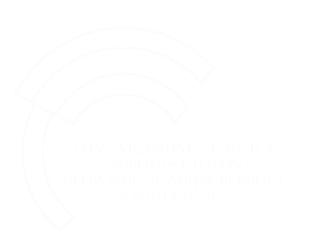Francesco Totti, Fiorello, Gianni Morandi, Carlo Verdone, Claudio Amendola: sono alcuni dei testimonial scelti dalla presidente della Camera dei deputati, Laura Boldrini per la campagna #BastaBufale.
"Ho deciso di lanciare questo appello - scrive la presidente - perché ritengo che il web sia un importante strumento di conoscenza e democrazia. Ma spesso anche luogo di operazioni spregiudicate, facilitate dalla tendenza delle persone a prediligere informazioni che confermino le proprie idee. In rete sono nati fenomeni nuovi, come le fabbriche di bufale a scopo commerciale o di propaganda politica e certo giornalismo 'acchiappaclick', più interessato a incrementare il numero dei lettori anziché a curare l'attendibilità delle fonti".
Un "Appello per il diritto a una corretta informazione" che ricalca una questione richiamata più volte, negli ultimi mesi, dalle principali testate giornalistiche, non solo italiane. Si sono rincorsi editoriali, commenti, suggerimenti anche da parte di esponenti delle istituzioni e delle Autorità di garanzia.
Il problema di fondo però è l'impatto sociale delle notizie diffuse sul web e rilanciate dai social network. La rapidità con la quale vengono lette, la capacità di chi le posta di inserire elementi emozionali, gli algoritmi che le rilanciano con estrema rapidità in funzione dell'interesse dimostrato sono elementi che complicano ulteriormente la situazione.
Mentre in Italia il problema è stato sollevato dalla presidente della Camera dei deputati e si concluderà probabilmente con una sollecitazione a prevedere azioni legislative, in Germania il Governo si è già mosso alla fine del 2016, prevedendo una sanzione fino a 500mila euro per quei social network che distribuiscono fake news.
Una presa di posizione che ha indotto Mark Zuckerberg a introdurre una versione pilota del programma anti fake news anche per l'Europa. Lo stesso pensato in USA per placare le polemiche sorte subito dopo le elezioni presidenziali. Saranno però direttamente gli utenti che dovranno segnalare le notizie false nel news feed degli utenti di Facebook.
Un problema rilevato, intorno al 7 marzo, anche per il principale motore di ricerca, Google. La Bbc ha fatto un esperimento con il device Google Home (non ancora disponibile in Italia) che, attraverso un assistente vocale, fornisce notizie e risposte agli utenti. In particolare, è stata posta una domanda su un possibile colpo di stato di Barack Obama. Il dispositivo ha evidenziato relazioni tra l'ex presidente USA e comunisti cinesi in base a news assemblate con gli spinnet, cioè le brevi descrizioni che si leggono quando si interrogano i motori di ricerca.
Un tema, quello delle fake news, che riguarda molto da vicino i comunicatori pubblici, sempre più costretti a gestire situazioni quotidiane di crisi, rincorrere affermazioni false diffuse e rilanciate in rete, piuttosto che concentrare la propria attività su strategie che rendano realmente il cittadino e le sue esigenze al centro dell'attenzione delle istituzioni.
Una questione che ci permette di ribadire la necessità di avere persone specificamente formate e, quindi, altamente qualificate a coordinare e gestire gli uffici di comunicazione degli Enti pubblici. Perché, come in medicina, se non si investe sulla prevenzione (l'alta professionalità) si rischia di spendere molto di più nella cura (i danni, anche di immagine, arrecati dalla diffusione di notizie false).
"Ho deciso di lanciare questo appello - scrive la presidente - perché ritengo che il web sia un importante strumento di conoscenza e democrazia. Ma spesso anche luogo di operazioni spregiudicate, facilitate dalla tendenza delle persone a prediligere informazioni che confermino le proprie idee. In rete sono nati fenomeni nuovi, come le fabbriche di bufale a scopo commerciale o di propaganda politica e certo giornalismo 'acchiappaclick', più interessato a incrementare il numero dei lettori anziché a curare l'attendibilità delle fonti".
Un "Appello per il diritto a una corretta informazione" che ricalca una questione richiamata più volte, negli ultimi mesi, dalle principali testate giornalistiche, non solo italiane. Si sono rincorsi editoriali, commenti, suggerimenti anche da parte di esponenti delle istituzioni e delle Autorità di garanzia.
Il problema di fondo però è l'impatto sociale delle notizie diffuse sul web e rilanciate dai social network. La rapidità con la quale vengono lette, la capacità di chi le posta di inserire elementi emozionali, gli algoritmi che le rilanciano con estrema rapidità in funzione dell'interesse dimostrato sono elementi che complicano ulteriormente la situazione.
Mentre in Italia il problema è stato sollevato dalla presidente della Camera dei deputati e si concluderà probabilmente con una sollecitazione a prevedere azioni legislative, in Germania il Governo si è già mosso alla fine del 2016, prevedendo una sanzione fino a 500mila euro per quei social network che distribuiscono fake news.
Una presa di posizione che ha indotto Mark Zuckerberg a introdurre una versione pilota del programma anti fake news anche per l'Europa. Lo stesso pensato in USA per placare le polemiche sorte subito dopo le elezioni presidenziali. Saranno però direttamente gli utenti che dovranno segnalare le notizie false nel news feed degli utenti di Facebook.
Un problema rilevato, intorno al 7 marzo, anche per il principale motore di ricerca, Google. La Bbc ha fatto un esperimento con il device Google Home (non ancora disponibile in Italia) che, attraverso un assistente vocale, fornisce notizie e risposte agli utenti. In particolare, è stata posta una domanda su un possibile colpo di stato di Barack Obama. Il dispositivo ha evidenziato relazioni tra l'ex presidente USA e comunisti cinesi in base a news assemblate con gli spinnet, cioè le brevi descrizioni che si leggono quando si interrogano i motori di ricerca.
Un tema, quello delle fake news, che riguarda molto da vicino i comunicatori pubblici, sempre più costretti a gestire situazioni quotidiane di crisi, rincorrere affermazioni false diffuse e rilanciate in rete, piuttosto che concentrare la propria attività su strategie che rendano realmente il cittadino e le sue esigenze al centro dell'attenzione delle istituzioni.
Una questione che ci permette di ribadire la necessità di avere persone specificamente formate e, quindi, altamente qualificate a coordinare e gestire gli uffici di comunicazione degli Enti pubblici. Perché, come in medicina, se non si investe sulla prevenzione (l'alta professionalità) si rischia di spendere molto di più nella cura (i danni, anche di immagine, arrecati dalla diffusione di notizie false).
Claudio Trementozzi