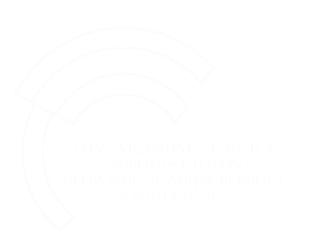Con la pubblicazione delle ultime quattro considerazioni e delle conclusioni termina la proposta delle riflessioni ricavate dall'indagine "Infosfera italiana 2016", realizzata dal Centro Studi Democrazie Digitali e che "Compubblica" ha supportato.
L'indagine completa è visibile su: http://democraziedigitali.it
Gli algoritmi che decidono per noi
Le merci vengono sistemate secondo indicizzazioni per priorità in modo da presentare tutto quello che ci piacerebbe, così come le notizie on line vengono presentate come le notizie che fanno per noi.
Due diverse persone che si rivolgono a un motore di ricerca con la stessa domanda non ricevono necessariamente le stesse risposte.
Il concetto di verità viene relativizzato e individualizzato, e così perde il suo carattere universale. L'informazione viene presentata come gratuita. In realtà, il destinatario la paga fornendo dati da sfruttare a persone che gli sono in accordo con una più ampia tendenza a modificare l'idea tradizionale di scelta umana.
E di nuovo torna il fascino perverso dei "giardinetti recintati" che le corporation costruiscono attorno ai loro utenti. Dove tutto ci spinge sempre più verso una vita googlizzata nella società della consultazione on line: sono i motori di ricerca (leggasi: Google), i social network come Facebook e Twitter a creare automaticamente le nostre relazioni sociali, e "quel che percepiamo come personale viene ridefinito dal sistema come qualcosa da dare in pasto al motore".
Il limite gnoseologico
Il bisogno di essere costantemente in rete, il bisogno di apparire, l'incapacità di pensiero profondo, la memoria labile, la dipendenza dal gruppo e da un ambiente tecnologico in cui la domanda di conoscenza e di informazione non nasce da percorsi di ricerca individuali bensì di emozioni, pratiche e decisioni collettive, condivise dal gruppo di riferimento, modificano profondamente i processi di conoscenza.
I contenuti della conoscenza non contano in quanto tali, ma assumono significato e rilevanza esclusivamente alla situazione contingente; la maggior parte delle conoscenze e delle informazioni che desideriamo ottenere è a un click di distanza, per cui esigiamo risposte immediate e rifiutiamo di perdere leggendo libri.
La riduzione a routine di comportamento condizionate dalla continua fruizione mediologica di ambienti social, l'occupazione ossessiva del tempo di vita e della nostra attenzione da parte delle timeline di nostro interesse sono un limite gnoseologico, una gabbia epistemologica di framing imposti, un dominio dei sensi e delle emozioni, una prigione cognitiva.
Nuova forma di coscienza
In questa gabbia, il sistema di reputazione, simulcro di qualsiasi matrice cognitiva si voglia organizzare, genera un'influenza egemone e diffusa sul reale, più difficile da definire perchè agisce sll'interpretazione del mondo attraverso specchi interposti e meccanismi di influenza biopoliticaa ed esperenziale.
Nel mondo contemporaneo, la coscienza umana prende forma tramite un filtro senza precedenti. Televisione, computer e smartphone formano una tripletta che offre un'interazione quasi costante con uno schermo durante tutto il giorno. Le interazioni umane nel mondo fisico vengono inesorabilmente sospinte nel mondo virtuale dei dispositivi connessi in rete.
Soggettività biomedica
Internet nella sua complessità di ambienti e di sistemi di informazione, ha avviato un'era biomediatica, caratterizzata dalla trascrizione virtuale e dalla condivisione telematica delle biografie personali attraverso i social network e dalla trasformazione delle categorie di pubblico/privato.
L'emotional sharing, la condivisione emotiva dei contenuti, si impone sul diritto alla riservatezza: l'io è il contenuto e il disvelamento del sè digitale è la prassi.
Il torrente continuo di informazioni scivola ormai sui sempre-connessi che vivono tra uno stato di narcosi e l'iper eccitazione chimica dello stimolo a competere.
Da questo punto di vista, Facebook si inserisce a pieno titolo nella grande saga della costruzione della soggettività, mentre Google della costruzione di gabbie gnoseologiche e di gestione della percezione; entrambe caratterizzano in modo essenziale la contemporaneità.
Conclusioni
Allo smart power degli ambienti mediatici transmediali che tendono a manipolare e gestire la percezione della realtà, l'individuo tende a reagire.
L'individuo incomincia a formare una ipersensibilità, seppur non del tutto espressa, che inizia a porre in discussione la fiducia e la credibilità delle fonti informative ma è condizionata dal proprio echo chamber e dall'influenza delle proprie reti omofiliache.
Questa nuova soggettività biomediatica fa apparire gli individui come su delle zattere violentemente sospinte dalle correnti informazionali, che solo a volte riescono a surfare, capendone limiti, criticità e problematicità. Molte volte, se pur alla ricerca di ancoraggi stabili e appigli, l'individuo sembra andare alla deriva della disinformazione e della manipolazione cognitiva.
(5- fine)