Obiettivo principale dell'indagine "Infosfera2016" (vedi "Comunicatori&Comunicazione" n. 182) è cercare di capire quali siano i criteri di scelta delle fonti di informazione degli utenti italiani e, in particolare, di comprendere quali sono i meccanismi di influenza dei media, soprattutto quelli presenti su Internet e la loro efficacia in termini di presentazione.
Proponiamo tratte dal report, partendo da un chiarimento sul significato del termine "infosfera", le prime cinque (su 22) considerazioni sulle trasformazioni e lo sviluppo delle reti di comunicazione interattiva e orizzontale.
Nei prossimi numeri di "Comunicatori&Comunicazione" proseguiremo con la pubblicazione.
Infosfera
Il termine "infosfera" designa l'insieme dei mezzi di informazione e comunicazione, nonchè il complesso delle informazioni che circolano attraverso questi mezzi. Si tratta della globalità dello spazio informativo, un ambiente dove gli organismi si formano come cellule interconnesse attraverso quei flussi informativi che continuamente lo attraversano.
L'utente compone i suoi palinsesti personali
La definitiva affermazione delle tecnologie digitali, nel solco di quella che Manuel Castells definisce Mass-Self-Communication, ha oramai sancito la centralità dell'utente all'interno della dinamica di questi flussi: orientandosi con disinvoltura tra vecchi e nuovi media e attingendo indifferentemente da questi sulla base delle proprie esigenze estemporanee, l'utente compone i propri palinsesti personali, scegliendo i contenuti sulla base del proprio interesse secondo i tempi e i modi a lui più consoni, assecondando i suoi gusti, i suoi desideri e i suoi bisogni, finendo per organizzare una miscela di consumi mediatici a misura di se stesso.
Si tratta a ben vedere di una dinamica che arriva a sovvertire lo stesso modello elementare della comunicazione secondo cui il ricevente è l'elemento che recepisce il messaggio, ma non è il diretto interessato, mentre il destinatario è la persona a cui il messaggio è rivolto.
Autismo comunicazionale
L'inedito processo di autoproduzione di contenuti e palinsensi a cui stiamo assistendo ridisegna in effetti un nuovo scenario in cui l'individuo si specchia nei media (ne è il contenuto) creati dall'individuo stesso (che ne è anche il produttore), in un gioco autoreferenziale di riflessi, arrivando de facto a cedere agli altri il solo ruolo di spettatore. Una dinamica che sembra tendere ad un certo autismo comunicazionale. Basti guardare alle logiche intriseche dei processi comunicativi in atto nel contesto ambientale dei Social Network: il destinatario di un qualsiasi atto comunicativo, attivo o passivo che sia, è relegato al solo ruolo di pubblico potenziale di una narrazione alla quale può rispondere - qualora non ne resti indifferente - con un "mi piace" o "non mi piace". Un'esile logica binaria, sostenuta dalla stessa architettura del medium, che facilita la polarizzazione e motiva e finisce per spazzar via qualsiasi contributo attivo da parte dei soggetti coinvolti nel processo di comunicazione - mittente e destinatario - nella costruzione di senso.
Superamento dimensione gerarchica/intermediazione
Questo comportamento supera la dimensione gerarchica, che attribuiva alle fonti tradizionali il ruolo insostituibile ed esclusivo di emittenti dei messaggi professionali e autorevoli dell'informazione mainstream, sostituita dalla prassi dell'autocomposizione delle fonti nell'ambiente web e da una matrice di flussi continui di informazioni propagate in una dimensione orizzontale.
Disintermediazione
La costruzione autonoma di percorsi individuali di fruizione dei contenuti e di accesso alle informazioni - svincolata dalla logica top-down e dalle logiche di intermediazione del passato che implicavano non solo l'ancoraggio alla rigida programmazione delle emittenti tradizionali e una comunicazione unidirezionale e verticale dei messaggi da parte delle fonti ufficiali destinata a un pubblico passivo - ha comportato una evoluzione dei meccanismi di influenza sociale e ha generato comportamenti, da parte degli utenti, sempre più funzionali alle logiche di personalizzazione, basata su codici e algoritmi di tracciamento destinati ad accertare i precedenti e le preferenze di ogni utente.
In questo scenario i creatori/produttori di contenuti possono ipotizzare - grazie alle potenzialità del contatto tutti-tutti offerte dalle reti di telecomunicazione digitale – di eliminare molti dei punti di intermediazione con i fruitori dei contenuti (Kelly, 1998, Roncaglia, 2011).
La disintermediazione digitale comporta la trasformazione da molare a molecolare (Lévy, 1994) della logica di creazione, produzione e diffusione del capitale simbolico e con essa la transizione dal paradigma dal centro alla periferia di McLhuan, al paradigma di una rete, in cui ciascuno dei nodi assume un potenziale maggiore a seconda dei contatti e delle transizioni di natura commerciale, sociale o culturale che intermedia.
(1 - continua)
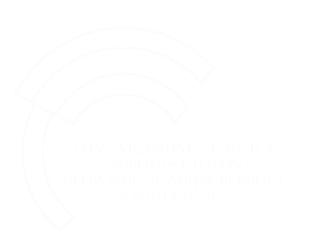
Chi siamo
Contattaci
Lunedì della 9:30 alle 15:30
dal martedì al venerdì dalle 9:30 alle 14:30.
dal martedì al venerdì dalle 9:30 alle 14:30.
Via Marsala 8 - 20121 Milano
Comunicazione Pubblica
Archivio newsletter - Associazione Italiana per la Comunicazione Pubblica e Istituzionale





