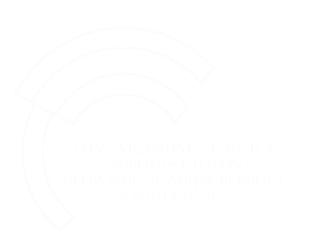Siamo migrati da una società della comunicazione alla società della conversazione: evitare il contraddittorio e la mediazione giornalistica è diventato il nuovo mantra dei politici. Propaganda e fake news dilagano, e pazienza se così la verità muore e la democrazia si indebolisce.
"Negli ultimi dieci anni si è consumata una trasformazione radicale e profonda nel nostro modo di comunicare. Siamo migrati da una società della comunicazione - l'era dei mass media, dove l'informazione viaggiava da uno a molti - alla società della conversazione - l'era dei personal media, con lo scambio di informazioni da molti a molti. Poiché quando cambia il nostro modo di comunicare è tutta la società che cambia, appare lecito chiedersi se il linguaggio dei social media sia consustanziale alla rinascita dei populismi che attraversa gli Stati.
Nell'Italia dialettale del dopoguerra, la televisione ha avuto un ruolo fondamentale nella riunificazione della lingua. I cittadini cercavano faticosamente di innalzare il proprio linguaggio mutuando espressioni colte dai mass media. Il parlare forbito e appassionato della politica era un esempio. Oggi stiamo assistendo a un processo inverso: sono i politici ad aver adeguato il proprio linguaggio a quello del pervasivo 'social media bar', dove contano lo slogan, la battuta pronta, l'aggressione verbale, più che la logica del ragionamento. Così, il linguaggio della conversazione - informale, colorito, spesso assertivo, a tratti strampalato e provocatorio - è penetrato nella politica con i risultati che sono sotto gli occhi di tutti: a destra e a sinistra, dall'Europa agli Stati Uniti.
Come ha sintetizzato Denise Pardo sull' "Espresso", "nella nuova politica, voto a parte, l'indicatore numero uno è il pollice". Il 'pollice di Internet', come già nell'antica Roma, è diventato l'indice di sopravvivenza politica ben più di altri parametri, come lo spread, ostici da capire, e quindi rappresentati come frutto di complotti delle élite nemiche del popolo.
Scoperte le virtù, e oscurati i vizi, del nuovo canale di conversazione, i politici se ne sono impossessati: evitare il contraddittorio e la mediazione giornalistica per molti di loro è diventato il nuovo mantra. Facebook, Twitter, YouTube, Instagram, tutti si sono rivelati funzionali allo scopo: la 'notizia' non è più quella che nasce da un confronto e dalla verifica, ma quella che la 'fonte' diffonde secondo un pensiero unico: il suo. E pazienza se così la verità muore e la democrazia si indebolisce. Lo ha spiegato con chiarezza il vice premier e ministro dell'Interno, Matteo Salvini, il politico europeo più seguito (il pollice su), nel corso di una diretta video su Facebook: "Quando faccio il comunicato stampa, poi i giornalisti scrivono tutte le loro cose…". Ecco, appunto. La confusione tra informazione e conversazione è racchiusa in questa semplice, efficace, trasparente motivazione: un politico usa i social come vuole, ma non può pretendere di fare la stessa cosa con giornali, radio, televisioni. Non almeno finché su questi media si continuerà a fare giornalismo con determinate regole deontologiche ed etiche. Ma, al di là delle responsabilità dei giornalisti, che pure sono evidenti, non possiamo non considerare che il campo di gioco è cambiato. Nell'era dei mass media i giornalisti erano i 'gatekeeper', i guardiani dei cancelli dell'informazione: da loro si doveva passare se si voleva raggiungere un'audience e incidere sulla formazione dell'opinione pubblica. Viceversa, nell'era dei personal media i giornalisti sono percepiti come una fastidiosa (inutile?) presenza professionale, da evitare perché possono frapporsi nella conversazione tra il comunicatore e il 'popolo'.
Il modello 'personal media' si è talmente radicato nello stile dei politici che molti di loro pretendono di applicarlo anche sugli altri media, alla televisione in particolare, dove evitano il contraddittorio, pretendono di essere 'ospiti solitari' o, almeno, di scegliere gli interlocutori, politici o giornalisti che siano. Il proclama, vero o falso, vince sul dovere di rispondere alle domande, il pensiero unico sul confronto delle opinioni, che dovrebbe essere la base per la formazione dell'opinione pubblica. Così, la propaganda, che erroneamente credevamo prerogativa dei regimi, vince sull'informazione".
Fonte: Marco Pratellesi, condirettore dell'Agenzia Giornalistica Italia, docente di Tecniche e Linguaggio del Giornalismo Multimediale presso l'Università Iulm di Milano e la Pontificia Università Lateranense di Roma - Internet day