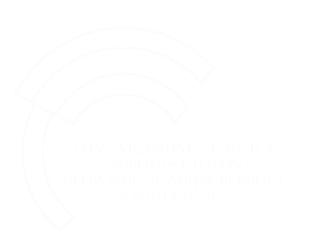Ancora tre definizioni sulle riflessioni nata dalla ricerca "Infosfera italiana 2016" realizzata dal Centro Studi Democrazie Digitali. (Per gli altri articoli vedi n. 184, 185 e 186 della newsletter)…
Il problema della selezione dei contenuti
Gli utenti sono portati a valutare attentamente i contenuti di un messaggio quando esso è rilevante per i loro interessi; al contrario quelli meno interessati al contenuto specifico del messaggio tenderanno a valutarne la "cornice" (fiducia, reputazione, credibilità della fonte; piacevolezza del comunicatore; gli aspetti stilistici o relativi al confezionamento dell'informazione).
L'emotional Sharing (la condivisione emotiva) determina lo spazio pubblico trasformato in opinione emotiva.
I neuroni a specchio ci servono a comprendere gli altri e sono alla base dell'empatia. Le narrazioni, attraverso il ricorso a forme e termini emotigeni, riescono meravigliosamente a indurre nel pubblico una situazione di marcata condivisione emotiva (emotional sharing).
Influencer vs reti omofiliache
L'opinione pubblica lascia il passo all'opinione emotiva, generata da immaginari a loro volta derivati dalla polarizzazione del sentimento (mi piace/non mi piace).
Gli influencer sono filtri: filtri della nostra attenzione, delle nostre emozioni, delle nostre labili opinioni. Gli influencer assumono il compito di manipolazioni automatiche dei motori di personalizzazione: in primo luogo perché ad essi viene assegnato un codice di riconoscimento, dopodichè, ogni volta che l'utente accede ai suoi post, ai suoi contenuti social, cede le porte di protezione al suo immaginario, condizionandone il sentimento che si trasforma in opinione emotiva.
I prosumer sono consumatori e produttori del versus che vuole l'influencer e allo stesso tempo elettori in quanto non solo esprimono consenso con il loro sentimento/voto ma in quanto 'eleggono' l'influencer ad hub e sorgente autorevole di condizionamento.
L'egosurfing (sistemi di software ideati per soddisfare le esigenze di navigatori narcisisti in cerca di informazioni su loro stessi) originariamente è stata la strategia per ottenere informazioni sulla sedimentazione di quei comportamenti che rispecchiavano assunzioni, stereotipi e luoghi comuni, sulle quali, oggi, le strategie di narrazione fondano la propria forza.
La comprensione dei meccanismi tribali, alla base delle regole di formazione delle reti egocentriche (Albert Lazlo Barabasi) e la cessione di fiducia e di consenso agli hub/influencer delle reti egocentriche, hanno generato una compressione delle informazioni generate dall'egosurfing, aprendo una nuova fase: quella delle tribù imaginifiche.
L'utente medio ignora che oltre quelle informazioni, trasformate in punti di vista e opinione emotive, c'è una realtà più complessa, a volte diversa, sicuramente meno banale, per cui non ha altra scelta che adattarsi all'esistenza per esserci.
Siamo di fronte ad un adattamento di tipo forzato: prima si instaura una relazione gerarchica tra influencer dominanti e individui "ancelle", che non si fonda sulla qualità, ma su meccanismi di indicizzazione emotiva; dopodichè la tecnologia conversazionale dominante obbliga gli individui ad adattarsi ad essa, manipolandone le esperienze cognitive.
Gli individui sono i prosumers dell'emotional sharing, trasformazione dell'opinione pubblica in opinione emotiva.
Niente "folle intelligenti", ma folle emotive, nessuna democratizzazione della cultura, ma onde di banale schiacciamento sulla mediocrità. Più forte è l'omofilia dei gruppi, ovvero la tendenza a frequentare solo gruppi di amici che la pensano come noi , maggiore sarà la radicalizzazione delle proprie posizioni e quindi la polarizzazione a diventare estrema.
Echo chamber
Secondo alcune recenti ricerche (Mit di Lucca) il fatto che informazioni diverse siano consumate allo stesso modo pone sostanzialmente due ipotesi: che le informazioni siano trattate indistintamente da tutti gli utenti a prescindere dal tipo di contenuto; che esistano gruppi di interesse focalizzati su specifici contenuti e che il loro comportamento sia universale rispetto al tipo di contenuto e narrativa scelti.
Quest'ultima è la più affascinante, perché ripropone il concetto di esposizione selettiva (confimation bias) e l'idea che il web, avendo facilitato l'interconnessione tra persone e l'accesso ai contenuti, abbia di fatto messo il turbo alla formazione di echo chamber, comunità che condividono interessi comuni, selezionano informazioni, discutono e rinforzano le proprie credenze attorno a una narrazione del mondo condivisa. Al crescere del numero di like su uno specifico tipo di narrativa aumenta linearmente la probabilità di avere una rete sociale virtuale composta solo da utenti con lo stesso profilo. Ovvero, si è più esposti a uno specifico tipo di narrazione, più aumenta la probabilità che tutti gli amici di Facebook abbiano la stessa attitudine al consumo di informazioni.
Le implicazioni di queste caratteristiche della rete sociale che si vede divisa in gruppi omogenei in base al tipo di contenuto fruito è fondamentale soprattutto per la comprensione della viralità dei fenomeni. Questi gruppi omogenei tenderanno a escludere tutto quello che non è coerente con la propria narrazione del mondo. Quindi è una struttura che facilita il rinforzo e facilita la selezione dei contenuti per confirmation bias.
(4- continua)