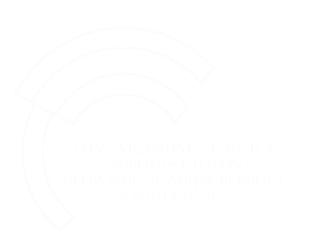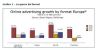Se dobbiamo scrivere che una cosa è verde, non è necessario spiegare che è il risultato della combinazione di due colori primari. Una guida dell'Accademia della Crusca e dell'Ittig riapre il dibattito su come debbano essere scritti gli atti. In giugno un seminario.
Il testo prescrittivo deve essere anche comunicativo. Solo così si riuscirà realmente ad abbattere quella barriera che divide l'Istituzione dal cittadino. Eppure su questo tentativo di garantire una "comunicazione circolare", sia all'interno degli Enti sia all'esterno, ci sono ancora molte resistenze. Dovute forse a un'eccessiva competizione tra linguisti, giuristi, comunicatori pubblici e, aggiungerei, politici... che non perdono in vizio di mettere lo zampino in ogni questione, nonostante la chiara separazione di competenze stabilita dal D.lgs 267/2000.
Un tema non nuovo
Il tema della semplificazione non è certo nuovo. Fin dagli anni Novanta, con le Bassanini, il legislatore ha tentato di svecchiare la pubblica amministrazione introducendo elementi di grande innovazione. Un percorso più volte ripreso, dibattuto, interpretato che ha portato a risultati sicuramente importanti sia a livello organizzativo interno sia nella relazione con l'esterno. Ogni volta che si è parlato di revisione dei processi, di modelli gestionali, di un'intensificazione della relazione con il cittadino, anche in termini di trasparenza e legalità, è sempre emerso il tema della semplificazione.
La Guida
È quindi sicuramente un passo importante, un buon inizio la prima "Guida alla redazione degli atti amministrativi: Regole e suggerimenti" messa a punto dall'Istituto di teoria e tecniche dell'informazione giuridica (Ittig) del Cnr e dall'Accademia della Crusca. Uno strumento di lavoro che prende spunto dalla "Direttiva sulla semplificazione del linguaggio dei testi amministrativi" del 2002 e dal manuale "Regole e suggerimenti per la redazione dei testi normativi" (2007) adottato dalle regioni italiane.
Un manuale che riprende e approfondisce le regole relative a ortografia, morfologia, lessico e sintassi, ma tenta anche di individuare un gruppo di linee guida "per definire una struttura standard di provvedimento amministrativo".
Non è sicuramente esaustivo, come hanno ammesso gli stessi curatori, ma un buon inizio. Anche dal punto di vista dell'approccio: "Ci rivolgiamo - si legge nella premessa - a quelli che non hanno una specifica formazione giuridica". Considerando i cittadini come destinatari finali.
Come è strutturata
È divisa in tre parti: una dedicata alle regole linguistiche, una alla struttura essenziale del provvedimento e la terza alle tecniche di redazione delle citazioni per il rinvio ad altri atti. Riprende, in qualche modo, il criterio delle cinque "W" del giornalismo (chi, come, dove, quando e perché) puntando sul "principio di economia linguistica (massima evidenza del significato e minimo sforzo di lettura da parte del destinatario)".
Il ruolo del comunicatore
Semplificazione, quindi, utilizzando un linguaggio più vicino al cittadino, cercando in qualche modo di "volgarizzare", senza esagerare per non perdere di vista il rigore delle disposizioni, i tecnicismi e puntare sulla chiarezza. O quasi. Se una cosa è verde, perché bisogna spiegarlo cominciando a raccontare l'origine del colore ciano e del giallo e poi arrivare a dire che, combinandoli, si crea il verde? Se il 74% del lessico della Costituzione riguarda il vocabolario di base, perché non possono esserlo gli atti predisposti da una P.A.?
Su questi aspetti il gruppo di lavoro che ha realizzato la guida ha preso in esame un testo amministrativo distinguendolo in quattro tipologie: testi con norme, modulistica, lettere, pubbliche affissioni. Con vincoli interpretativi che vanno, rispettivamente, dal più al meno stringente. "Cambiando, a seconda dello strumento, anche le parole". Se così è, diventa quindi ancora più strategico il ruolo del comunicatore, che non lavora in modo specifico sull'etimologia del termine (che è più di competenza del linguista), ma sa bene quanto sia importante farsi comprendere, soprattutto in un periodo in cui le contaminazioni del linguaggio sono numerose.
Perché, però, si riesca a raggiungere i veri destinatari, cioè i cittadini, occorre tenere presente che la comunicazione pubblica e istituzionale ha dinamiche ben più complesse, anche strategiche. Tanto che sempre più spesso il sistema del governo locale, dalle Regioni fino ai Comuni, si è reso conto che il comunicatore pubblico non può essere coinvolto solo nella fase conclusiva, di output, del processo, ma fin da quelle iniziali, appunto di strategia organizzativa.
Quindi un atto ben scritto, chiaro e semplice - facilmente comprensibile da un giudice di fronte al quale il provvedimento può essere impugnato, così come dal cittadino che non ha alcuna nozione non solo di diritto, ma anche di linguaggio eccessivamente burocratico - può diventare un potente punto di partenza per una buona comunicazione che, se vengono attivati percorsi di circolarità, diventa condivisione.
Il seminario
L'osservatorio sulla semplificazione del linguaggio, che si è costituito nei giorni scorsi a Firenze nel corso di una riunione tenutasi nella sede dell'Ittig del Cnr, ha proposto un primo seminario dal titolo "La legge come comunicazione di massa, tra passato e presente". È stata ipotizzata una data, il 10 giugno prossimo, ma il programma e i relatori sono ancora da definire nel dettaglio.
Un'occasione interessante di approfondimento, perché l'intenzione è di partire dalle forme di comunicazione pubblica del '500 fino ad arrivare ai giorni nostri, facendo un riferimento anche alla L. 150/2000 e ai suoi effetti.
Claudio Trementozzi