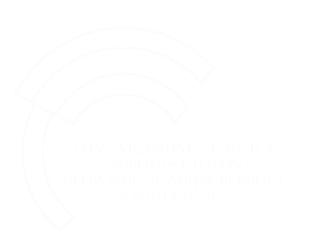Al centro dell'attenzione dei media e dei giornali vi è stata l'informazione fornita da scienziati, medici e operatori del settore sanitario.
Nella lotta al virus l'Italia si è distinta con misure di estremo rigore, decise dalle Autorità di governo in collaborazione con i poteri locali e regionali e i partner sociali, che sono diventate un modello per l'intera Europa.
Partendo da questo modello ci saremmo attesi un atto di responsabilità dei governi europei per attribuire alla Commissione europea i poteri di una "catena di comando" per gestire il coordinamento e le azioni comuni applicando quelle norme del Trattato che danno all'Unione la competenza di agire per la sicurezza nel settore della salute (art. 168 TFUE), per coordinare la cooperazione fra gli Stati in materia di protezione civile (art. 196 TFUE) e per dare adeguata esecuzione alla clausola di solidarietà (art. 222 TFUE).
Ci saremmo anche attesi una comunicazione pubblica omogenea europea, rivolta a tutte le cittadine e i cittadini europei per informare sulle ragioni e sugli effetti di una pandemia simmetrica sottolineando quel che può fare e deve fare l'Unione europea per garantire il bene pubblico della salute e sfruttando reti di collaborazione e di coordinamento fra le Amministrazioni nazionali come il Club di Venezia, fondato nel 1986 da Stefano Rolando, come luogo di incontro permanente fra i responsabili dell'informazione e della comunicazione dei governi nazionali e delle Istituzioni europee.
Il rispetto, individuale e collettivo, di queste misure è stato il frutto contestuale di un impegno civico largamente diffuso in tutto il Paese e dell'attività di comunicazione pubblica, altamente professionale, degli operatori sia della comunicazione che dell'informazione nelle Amministrazioni locali, regionali e nazionali che hanno tradotto – lontano dai riflettori dei media ma con una abnegazione pari a quella degli operatori sanitari – le decisioni legislative in una nuova narrazione e in un rapporto costante con i cittadini.
Di fronte agli effetti di un'emergenza inattesa, i comunicatori pubblici e istituzionali sono stati chiamati ad innovare il loro linguaggio di fronte alle nuove necessità, a interpretare dei testi giuridici di immediata applicazione, a gestire il numero crescente di domande della pubblica opinione, a controllare la buona applicazione delle decisioni a tutti i livelli, a dialogare costantemente con i vari protagonisti della vita civile e ad agire con flessibilità.
Trascorsa la fase dell'emergenza, verrà il momento di riflettere sul ruolo esercitato dagli operatori della comunicazione pubblica e tradurre l'esperienza di questa crisi in una accentuata valorizzazione della loro professionalità offrendo, a questo settore della funzione pubblica, gli strumenti digitali per un'erogazione più efficace dei servizi di comunicazione.
In questo quadro sarà urgente e necessario applicare pienamente la Legge 150 del 7 giugno 2000 che disciplina le attività di informazione e di comunicazione delle Pubbliche Amministrazioni garantendo una precisa distinzione fra l'informazione svolta dagli uffici stampa e dai giornalisti e la comunicazione pubblica garantita dalle Pubbliche Amministrazioni a livello locale, regionale e nazionale con particolare riferimento al settore della salute e dell'ambiente. In questo quadro si colloca l'opportuna iniziativa del Ministero della Funzione Pubblica per sfruttare le possibilità offerte dalla Legge 150 e aggiornarle a venti anni dalla sua entrata in vigore.
Poiché quest'anno molti responsabili della comunicazione pubblica andranno in pensione bisognerà sfruttare questa occasione per innestare nelle Pubbliche Amministrazioni linfa vitale rafforzando le attività di formazione, attività che vengono svolte da anni da "Compubblica" e che proseguono on line anche in questo periodo, attraverso webinar gratuiti e aperti.
Pier Virgilio Dastoli