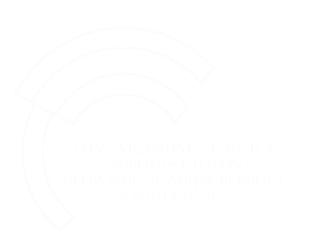Quali sono i criteri di scelta delle fonti di informazione da parte degli utenti italiani? Cosa regola i meccanismi di influenza dei media, in particolare quelli presenti su Internet, e la loro efficacia in termini di persuasione?
A queste domande risponde l'indagine “Infosfera 2016”, promossa e coordinata dall'Università degli studi Suor Orsola Benincasa e realizzata da un team di ricercatori del Centro Studi Democrazie Digitali, supportati da Buzzlogger e dall'Associazione Italiana della Comunicazione Pubblica e Istituzionale.
I dati, raccolti tra dicembre 2015 e gennaio 2016 attraverso interviste dirette (1.157 questionari su tutto il territorio nazionale), si rivelano utili a inquadrare le dinamiche in atto all'interno del più ampio contesto dell'infosfera, ovvero la globalità dello spazio informativo che contiene l'insieme dei mezzi di informazione e comunicazione, nonché il complesso delle informazioni che circolano attraverso questi mezzi.
I risultati della ricerca, pubblicati a luglio all'interno del report “Infosfera Italiana 2016”, rappresentano un primopunto di partenza per leggere le principali trasformazioni in atto e ipotizzare rinnovati meccanismi di generazione di senso comune e di costruzione degli immaginari collettivi e individuali nell'era della mass-self-communication, in cui le persone, orientandosi con disinvoltura tra vecchi e nuovi media e attingendo indifferentemente da questi sulla base delle proprie esigenze estemporanee, compongono i propri palinsesti personali, scegliendo i contenuti sulla base del proprio interesse secondo i tempi e i modi a lui più consoni, assecondando i suoi gusti, i suoi desideri e i suoi bisogni, finendo per organizzare una miscela di consumi mediatici a misura di se stesso.
Alcuni tra i principali focus tematici dell'indagine:
1) Dieta Mediatica
Le fonti di informazione più utilizzate dalle persone sono i motori di ricerca on line, seguiti dai telegiornali e dai siti web di informazione.
Se la Rete è ormai lo strumento primario per raccogliere informazioni, non è ancora il luogo della democratizzazione di massa, dato che solo il 34% degli utenti dichiara di partecipare alla vita politica e civile attraverso il web e i programmi tv di approfondimento restano ancora il media più seguito per la formazione delle opinioni politiche.
2) Il “Vampirismo” di Facebook
L'utilizzo di Facebook è al primo posto tra i principali utilizzi di Internet (il 75,98% degli utenti) e assorbe una quota estremamente significativa del tempo che le persone trascorrono in Rete. Un'esperienza “totalizzante” che per la maggioranza degli utenti, inesperti, rischia di ridurre la fruizione del Web a routine di comportamento condizionate.
3) La Percezione della Credibilità
In un contesto nel quale l'informazione è sovrabbondante, si assiste a una crescente scarsità di attenzione che ne aumenta il valore per chi riesce a produrla e rivenderla.
L'attenzione che si dedica agli amici e alle persone intime è incommensurabilmente più elevata di quella che si dedica ad altre e più impersonali fonti di messaggi.
Gli influencer sono filtri della nostra attenzione, delle nostre emozioni, delle nostre labili opinioni.
4) Echo chamber
Più forte è l'omofilia dei gruppi, ovvero la tendenza a frequentare solo gruppi di amici che la pensano come noi, maggiore sarà la radicalizzazione le proprie posizioni e quindi la polarizzazione a diventare estrema. Questi gruppi omogenei tenderanno a escludere tutto quello che non è coerente con la propria narrazione del mondo.
5) Incapacità di distinguere il reale dal falso
Oltre due terzi degli intervistanti non sono in grado di distinguere un sito di controinformazione e 9 persone su 10 non distinguono un profilo finto (cd. fake) da uno autentico.
Valentina Casiraghi
Ricerca